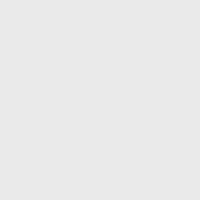“Un artefatto o un’impresa collettiva, capace di
crescere su sé medesima, volta a conoscere il
mondo e a intervenire sul mondo”. Questi,
secondo lo storico della scienza Paolo Rossi,
sarebbero i caratteri peculiari dell’impresa
scientifica, così come la conosciamo adesso ma
anche come apparve, circa cinque secoli fa, ai
suoi “padri fondatori”, manifestandosi
immediatamente come qualcosa di totalmente nuovo
nella storia del genere umano.
Ne “La nascita della scienza moderna in Europa”, libro piacevolissimo e di agile lettura, Rossi ci racconta i due secoli che videro nascere questa grande impresa collettiva. Si parte nel XVI secolo, quando ancora il sapere era detenuto dai maghi e dagli alchimisti e si intrecciava in maniera inestricabile con la nascente scienza, per arrivare alle teorie newtoniane (XVIII sec.), che segnano il definitivo consolidarsi di quel metodo scientifico, misto di pratica sperimentale e matematizzazione della realtà, che oggi ben conosciamo.
In mezzo c’è una storia affascinante quanto complessa, i cui protagonisti si chiamano Galileo Galilei, Niccolò Copernico, Giordano Bruno, Cartesio. Essi hanno contribuito a un sapere che si è posto sin da subito in aperta contrapposizione con la tradizione e con le idee filosofiche e teologiche del tempo e che è cresciuto costantemente, modificandosi e diversificandosi.
Rossi accetta l’idea di una forte discontinuità tra la tradizione scientifica medioevale e la scienza moderna e considera quindi perfettamente legittimo l’uso dell’espressione “rivoluzione scientifica”. Egli sottolinea inoltre il continuo dialogo critico tra le varie teorie e tradizioni scientifiche, offrendoci una visione sfaccettata e mai superficiale del loro sviluppo.